La metastasi della povertà
L’Europa tra Sette e Ottocento era “illuminata” e povera: il nuovo ordine promosso dai filosofi e dagli scienziati si scontrava con la decomposizione di un sistema feudale, che alimentava una povertà metastatica, generalizzata e diffusa. Il “pauperismo” era una mina vagante per il vecchio regime come per la rivoluzione. Ad esso faceva fronte quasi unicamente l’azione assisten-ziale della Chiesa, che non metteva però in discussione il sistema dei privi-legi, nel quale essa stessa era invischiata.
Un’economia centrata sull’agricoltura, gestita con la logica del latifondo e organizzata su base feudale, non riusciva a soddisfare i bisogni primari di tutta la popolazione. Dalla metà del Settecento in Italia vengono introdotte nuove colture e le aree coltivate sono ampliate, con interventi di disbosca-mento e di bonifica soprattutto al Nord. Ma il saldo alimentare è sempre ne-gativo. E così torme di poveri percorrono le vie delle città, vagano per le campagna, vivendo di elemosina e di espedienti di ogni genere.
A Napoli la situazione è particolarmente difficile. Gaetano Errico, bam-bino, ha certamente visto aggirarsi in città “turbolenti gruppi di lazzari in cerca di occasioni. Nuca rasata e ciuffo sulla fronte, seminudi in estate, vi-vono di espedienti; sempre pronti alla rissa e ad usare il coltello dietro ri-compensa. Relazioni di viaggio e cronache di gazzette li descrivono con di-sgustata riprovazione” .
I lazzari sono la frangia organizzata della miseria, cui il potere politico affida in più di qualche occasione il compito di controllare la città e il terri-torio. Li troviamo in prima fila anche nella disperata resistenza popolare (1799) contro i francesi, guidati dal capolazzaro Michele O’ pazzo, che di-venterà in seguito un acceso giacobino.
Oltre ai lazzari, in città e nelle campagne circostanti, vivono i poveri ab-bandonati a se stessi, tra cui numerosi nobili decaduti. Braccianti che non hanno una zappa per poter venire assunti a lavorare a ore. Contadini, schiavi dei latifondisti perché condannati a coltivare campi che non renderanno mai ciò essi devono per contratto dare ai padroni. Piccoli commerciati e artigiani braccati dagli strozzini, cui hanno chiesto denaro per poter avviare un’attivi-tà e dai quali non riescono più a liberarsi.
Una povertà diffusa, urlata o silenziosa, che poteva servire da massa di manovra in qualche occasione, ma che teneva costantemente il sistema so-cio-politico lontano dall’equilibrio. Le rivolte popolari e contadine erano al-l’ordine del giorno. In alcuni casi si coloravano di fondamentalismo religio-so e potevano scatenarsi, come in Toscana, al grido di “Viva Maria” ma in realtà esprimevano sempre e comunque la disperazione sociale ed economi-ca dei poveri. Lo spiega bene un manifesto comparso nel 1795 sui muri di Arezzo che incitava la popolazione alla rivolta contro le riforme, proposte dal nuovo regime, da cui derivavano aumento dei prezzi e disoccupazione. Si leggeva sul manifesto: “Sù dunque, viva la fede, si rispetti il tempio e il culto divino, e tutti quei che restano afflitti dall’ingordigia di simil baron fot-tuti al cenno, che datoli li sarà dalla campana di Pieve colla più barbara ve-locità tutti accorrano a trinciare alla peggio, a spargere quell’iniquo sangue, che altro non tende, che la nostra rovina e disperazione” .
La povertà si è sempre in qualche modo alleata alla religione. A Napoli, il generale francese Jacques Etienne Macdonald, comandante in capo delle operazioni nell’Italia meridionale, nel tentativo di sedare la tensione sociale latente, arriva (1798) a ordinare il miracolo di s. Gennaro fuori tempo. Il santo non gli dà retta e i napoletani ci ricamano sopra da par loro. La rivolu-zione che viene dalla Francia, promossa dagli agitatori giacobini, non è a fa-vore del popolo, è roba da ricchi: “Chi tene pane e vino/ ha da esse giacub-bino”.
Durante l’Impero napoleonico rivolte e sommosse popolari scoppiano in tutta Italia ma nel regno di Napoli hanno una violenza e una proporzione maggiore. Nasce in questo periodo quella specie di tradizione guerrigliera meridionale, cui farà ricorso anche il Risorgimento. Giuseppe Bonaparte, piazzato a Napoli dall’imperatore, tenta la strada della riconciliazione, ma deve fare i conti con la rabbia dei patrioti che rientrati dall’esilio pretendono un posto nell’amministrazione pubblica (nella cultura napoletana di allora l’impiego pubblico era considerato un favore non un impegno) e con i privi-legi dei burocrati francesi. Non cede. “A poco a poco, nel perseguimento del fine comune, le differenze politiche scomparvero e Giuseppe poté lasciare in eredità a Murat una classe dirigente ristretta, ma omogenea. Fra il gruppo dominante, che aveva l’appoggio dei proprietari terrieri e la grande massa contadina si collocava la piccola borghesia della capitale, sostanzialmente apatica e indifferente” .
Don Gaetano Errico conoscerà personalmente Murat e avrà modo di se-guire da vicino la politica di riforme da lui promossa, con l’intenzione di a-bolire definitivamente l’impianto feudale, di distribuire terre ai contadini e di riorganizzare lo stato su basi economiche e giuridiche più eque. Impresa du-rissima, per la reazione dei feudatari e per l’incapacità dei comuni di appli-care localmente le indicazioni legislative. Era, tra l’altro, difficilissimo tro-vare delle persone disposte a fare gli amministratori comunali, per la man-canza strade, di istruzione e di reddito adeguati, e soprattutto per la paura che ne andassero di mezzo la vita e la proprietà. D’altra parte, là dove si riu-sciva a sostituire i feudatari di un tempo con i galantuomini locali le prepo-tenze non cessavano: i nuovi esponenti dell’amministrazione non cambiava-no registro e corruzione e violenza continuavano a dilagare. Nella gente cre-sceva l’esasperazione.
Murat attua con grande energia le riforme progettate da Giuseppe Bona-parte e tenta addirittura (1811) di venire incontro alla grande voglia di indi-pendenza della popolazione, circondandosi solo di ministri napoletani e ren-dendo obbligatoria la cittadinanza napoletana per l’assunzione negli uffici pubblici. Ci aggiunge la bandiera nazionale e un forte esercito, ma non rie-sce a diminuire le forti tasse e a ridurre le conseguenze negative del blocco continentale. Perde ulteriormente consensi.
Nel 1813, Murat tenta una spericolata manovra politica: si allea con gli austriaci e con gli inglesi, tradendo Napoleone, che è sempre più in difficol-tà (sarà sconfitto a Lipsia nell’Ottobre dello stesso anno). Una scelta di cam-po, quella di Murat, difficile da reggere, anche psicologicamente. Nel 1814 fa di tutto per evitare di incrociare le armi con l’esercito del Regno Italico comandato da Eugenio Beauharnais (45 mila uomini, l’ultima compagine militare napoleonica). Dopo l’abdicazione di Napoleone (4 aprile 1814), Eu-genio tenterà di salvare il salvabile proclamando l’indipendenza del Regno Italico. Ma è troppo tardi: i patrioti non gli danno fiducia e scatenano la piazza.
Crollato il Regno Italico, Murat si trova ad essere l’ultimo esponente del-la dominazione napoleonica in Italia. Al Congresso di Vienna i suoi rappre-sentanti non vengono ammessi. Gioacchino allora si lancia in un doppio gioco disperato: cercare l’appoggio dei bonapartisti e dei liberali italiani, promuovendo nello stesso tempo l’indipendenza e l’unità dell’Italia. Ma non gli credono e paga con la morte l’ultima partita.
Don Gaetano vive sulla sua pelle questo tempo di transizione politica turbolenta e di povertà economica: la sua famiglia, che pure poteva puntare ad una ipotesi di benessere dal momento che operava in una settore sicuro come quello alimentare, perde progressivamente capacità di acquisto, e deve accontentarsi del magro reddito di un’attività tessile, agli albori dell’indu-strializzazione (la tessitura della felpa), tradizionale in quella zona, anche nel senso della precarietà che assicura. Conosce dunque di persona la pover-tà e convive con le conseguenze della medesima: violenza, sopraffazione, omertà, corruzione, degrado morale e vuoto culturale.
Ricava da questa esperienza un grande impulso alla solidarietà. Reazione eccezionale, se si pensa che i poveri, generalmente, ritengono di dover rice-vere e non di dover dare.
Don Gaetano è invece un povero che dà.
L’arte della solidarietà
“I poveri vanno sempre soccorsi, pensando che sono la persona di Gesù Cristo”, diceva don Gaetano. Ad essi riserva i proventi del ministero e della rendita patrimoniale, con grande dispiacere di sua mamma, sempre più in difficoltà a far andare avanti il telaio e la famiglia. Ma don Gaetano non s’è fatto prete per mantenere la famiglia. S’è fatto prete per i poveri e vuole che essi vengano sempre accolti e che, a tavola, per loro non manchi mai un piatto di minestra. Pascariello ‘o pazzo ci fa la firma e diventa ospite fisso in casa Errico.
Quando passava in chiesa per raccogliere l’elemosina usava una partico-lare tecnica per far pervenire il suo aiuto a qualcuno: gli porgeva il vassoio per ricevere una monetina di scarso valore e poi fingeva di dovergli dare il resto, mettendogli in mano qualche moneta più consistente. Alla fine in sa-crestia arrivava ben poco e spariva anche quello se qualche indigente si pre-sentava anche lì a cercare aiuto.
Don Gaetano dà quello che ha -scarpe, camicie, maglie e simili – e quel-lo che riceve. Si libera della roba, per gli altri.
Lo stile introdotto nella sua famiglia, viene riproposto in Congregazione. ‘O Fondatore vuole che nessun povero bussi alla porta delle sue case reli-giose senza venire accolto e accudito. Una disperazione per il cuoco e per l’economo, che credono certo nella Provvidenza ma hanno piatti da riempire ogni giorno e scadenze da onorare. Ragioni che per don Gaetano contano poco.
“Spesso autorizza artigiani disoccupati, con famiglia a carico, a preleva-re a suo nome, presso negozi alimentari, il necessario settimanale. Inoltre paga abitualmente la pigione per alcuni ammalati o a favore di famiglia mi-nacciate di sfratto per morosità; anzi riguardo a queste ultime non esita a farsi garante per il futuro” .
C’è dell’arte nel suo modo di servire i poveri, fatta di delicatezza e di-screzione. Agisce in modo da non offendere le persone e tiene sotto control-lo tutti gli effetti negativi della povertà: l’emarginazione sociale e la vergo-gna del nobile fallito; i rischi morali che corrono certe ragazzine costrette a vivere in ambienti malsani e squallidi, che colloca a proprie spese in qualche convitto.
Assistenza e interventi in emergenza, ma anche senso dello sviluppo o quantomeno promozione della dignità della persona. Allo zappaterra (così erano chiamati i braccianti) impossibilitato a lavorare perché privo di zappa, fornisce l’utensile per guadagnarsi da vivere. All’operaia sfruttata dai produt-tori tessili dà i soldi per acquistare un telaio e assicurarsi dignità professio-nale e autonomia economica.
Secondigliano vive di agricoltura e di artigianato tessile. Chi lavora deve manovrare tra sfruttatori e strozzini. Spesso per sopravvivere non c’è altro che la carità cristiana. E di essa è esponente noto e ammirato proprio don Gaetano. Carità ma anche giustizia, nel senso che si batte perché sia ricono-sciuta agli operai la giusta paga e perché si creino le condizioni per una equa divisione della ricchezza.
Presente ovunque c’è bisogno e sempre disponibile a rispondere alle ri-chieste di aiuto, lo troviamo anche nelle carceri. Ogni giovedì, dai primi an-ni di sacerdozio fino a quando le forze glielo consentono, si dedica ai carce-rati. Vivono in condizioni igienico-sanitarie disastrose e sono abbandonati a se stessi. Don Gaetano si fa portavoce delle loro esigenze presso i superiori e perora la causa dei suoi compaesani presso gli uffici giudiziari. Amico e avvocato di fiducia.
Colera
Napoli, nella prima metà dell’Ottocento, è stata interessata da due epi-demie di colera: nel 1836 e nel 1854. Due emergenze sanitarie, curiosamen-te previste dalle autorità ma che trovano impreparata la popolazione. Chissà perché.
Nella prima epidemia, che si manifesta in due fasi, muoiono a Napoli e dintorni quasi ventimila persone: una cifra spaventosa a fronte di una popo-lazione complessiva di 357 mila abitanti.
In entrambe le circostanze don Gaetano dà il massimo, senza preoccu-parsi del contagio. Vorrebbe che Secondigliano fosse risparmiata, a questo scopo organizza una processione di penitenza. Dopo l’omelia conclusiva, il sacerdote che guida l’azione liturgica – come si usava allora – inizia a darsi la disciplina imitato da tutti. Anche don Gaetano si flagella più volte con una grossa disciplina di maglie di ferro.
Il parroco pensa di poter rassicurare i suoi parrocchiani: il buon Dio ri-sparmierà i secondiglianesi. Ma don Gaetano prende la parola e gela l’udito-rio:
– Compaesani miei, mi dispiace purtroppo di dover contraddire il nostro Parroco. Poiché la nostra penitenza è stata soltanto esteriore e non tutti sono sinceramente pentiti delle loro colpe, il Signore sta per provare anche noi. Stasera stessa, uno dei giovani più robusti, qui presenti, morirà di colera e domani la medesima sorte toccherà ad un mio confratello nel sacerdozio.
Tutto si avvera puntualmente. Come si avvera puntualmente la profezia di don Gaetano alla mamma. La povera donna, ormai in età, si lamentava dei suoi acciacchi con una certa insistenza. Il figlio sacerdote le fa visita con frequenza. Ascolta e cerca di consolarla. Ma un giorno agli inizi del 1837 le annuncia in tutta la franchezza la data precisa della morte: il 19 aprile.
Don Gaetano, costretto a letto, non può assisterla e nemmeno partecipare ai funerali. Il feretro passerà proprio sotto la sua finestra e qualcuno tenterà di distrarlo, per non vederlo soffrire, ma don Gaetano ha un rapporto troppo concreto e ricco con la vita per aver paura della morte. Il legame con la ma-dre continuerà in un altro modo. L’amore va oltre la morte e non ha bisogno di consolazioni. Si immerge nella preghiera.
Nella sua arte di amare il prossimo don Gaetano dimostra di possedere alcuni particolari doni di preveggenza, che in paese e nella comunità fanno notizia. È un prete che vede lontano o quantomeno vede ciò che ad altri sfugge.
Il notaio Cosimo Miranda è disperato: sua figlia, pochi anni, è stata col-pita dal colera. I medici la danno per persa. Don Gaetano lo assicura invece che guarirà. Si mette in preghiera e 24 ore dopo la bambina è fuori pericolo. Il giorno dopo ancora la bambina si alza dal letto e riprende a giocare.
Don Gaetano lascia di stucco un uomo che il 6 luglio 1837 si avvicina al suo confessionale, come sempre attorniato di penitenti, dicendogli:
– Ho capito, sei venuto per don Giustino. Andiamo pure, ma lo trovere-mo morto.
Si trattava di un sacerdote molto buono, che viveva a Cesa, poco distante da Aversa e che aveva contratto il colera per assistere ammalati e moribon-di. Quando Don Gaetano e l’accompagnatore arrivano trovano già la camera ardente allestita. Don Gaetano chiede di restare solo con il defunto. Una so-rella del sacerdote origlia e sente i due che parlano tra loro. Una conversa-zione che dura circa mezz’ora. Poi don Gaetano esce, assicurando tutti che non dovevano piangere affatto per il defunto: Don Giustino è un martire del-la carità cristiana e non ha nulla da temere dalla morte.
Durante il colera del 1854 impegna tutta la sua comunità nell’assistenza agli ammalati. Mette a disposizione la sua casa per lo stoccaggio delle scorte dei prodotti di prima necessità destinati ai colerosi, forniti dall’amministra-zione pubblica: coperte, biancheria intima, medicinali, zucchero, limoni, lenzuola. Incarica il nipote P. Beniamino di gestire il servizio con la mas-sima disponibilità ed efficienza: nessuna richiesta doveva essere respinta, arrivasse di giorno o di notte. La portineria della casa doveva restare sempre aperta.
Si alterna tra il confessionale e il letto dei moribondi, invitando i peni-tenti a pazientare e aiutando i malati a riconciliarsi con Dio prima del grande passo.
Una questione d’amore
Una certa tradizione agiografica ha raccontato che i santi si riconoscono da alcuni segni particolari, quasi degli effetti speciali, prodotti da essi o da Dio a loro favore. Il santo insomma è uno che fa miracoli, vede nel futuro, va al di là delle leggi fisiche, tocca Dio e ne viene, a sua volta, toccato. Un personaggio fuori dalla normalità, diremmo. Paranormale o soprannaturale? Chissà. Con le categorie in voga si fa poca strada per capire la santità.
Anche nella vita di don Gaetano sono registrati dei fatti eccezionali, al-cuni dei quali abbiamo raccontato anche noi. Ma noi, nel valutare questi e-venti, vorremmo adottare l’atteggiamento di don Gaetano, che, interrogato su certe sue sorprendenti “profezie” ha risposto:
– Che devo dire? Il Signore me lo mise in bocca e io lo dissi.
Ovviamente il Nostro glissa sul fatto che il Signore si sia rivolto proprio a lui e non ad altri. Il che rende ancora più intrigante tutta la faccenda.
Anche Gesù, quando compiva un miracolo, scatenava curiosità e stupo-re. Oggi abituati come siamo agli effetti speciali della realtà virtuale (dal computer al cinema) siamo piuttosto anestetizzati sia rispetto alla curiosità che rispetto allo stupore. In tutti i casi non siamo mai sazi di eventi eccezio-nali e li cerchiamo in continuazione. Eccessivi in tutto, cerchiamo eccessi anche nella santità. E li chiamiamo miracoli.
Questo ci impedisce di capire e di godere il fascino straordinario della normalità che la santità introduce invece nel quotidiano di una persona. Don Gaetano è un normalissimo prete, nel senso che ha deciso di fare il prete se-condo la “norma”, codificata soprattutto nel Vangelo e consolidata nella tradizione della Chiesa. Ed essendo un normalissimo prete, fa di tutto per essere un buon cristiano, uno cioè che ama i suoi fratelli e Dio. E così svi-luppa in modo molto coerente il progetto proposto dal Vangelo.
I risultati sono particolarmente brillanti, dal momento che don Gaetano ha studiato a fondo la Parola. E agisce di conseguenza, applicando al meglio le indicazioni del Maestro circa il modo di instaurare il Regno (nuovo cielo e nuova terra): “Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bi-saccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento” (Mt 10, 7-10).
È tutto molto semplice: don Gaetano sa benissimo che se Gesù gli dice di resuscitare un morto non c’è altro da fare che resuscitarlo. Le regole e-vangeliche non hanno bisogno di particolari interpretazioni: funzionano solo se vengono applicate, per quello che sono. A fare la differenza è il livello della fede. Don Gaetano crede veramente che il Regno di Dio sia instaurato e che compito del cristiano sia quello di metterlo a disposizione di tutti. Il suo successo sta tutto qui.
Gli apostoli al rientro dal primo raid apostolico erano tutti eccitati perché avevano sperimentato che Gesù non scherzava affatto e che se diceva loro di scacciare i demoni gli riusciva alla lettera. Don Gaetano può far propria la loro esperienza, dispensandosi dal dubbio e persino dalla sorpresa. Sono gli altri che devono rimanere a bocca aperta.
Lui si impegna semplicemente a creare in sé le condizioni adatte per rea-lizzare il progetto evangelico. Come?
Prega molto, fino a consumare fisicamente le ginocchia e a scavare il pavimento della sua camera. La sua è una preghiera continua, intensa, si-stematica, secondo le precise indicazioni del Maestro: “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve acca-dere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21,36); “Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo otte-nuto e vi sarà accordato” (Mc11,24).
La preghiera è un modo di dialogare con Dio, ma anche una tecnica per ridurre la complessità della nostra esistenza, per diventare leggeri. Per farsi compenetrare da Dio, ma anche dalla realtà e poter ammirare entrambi (Dio e la realtà) in maniera quasi diretta. Più che una lente di ingrandimento, la preghiera è un laser che ci svela il reale nella sua struttura profonda.
L’effetto preghiera è esaltato attraverso quella che la tradizione spirituale occidentale ha chiamato penitenza. Don Gaetano, fin da giovane, l’ha prati-cata con una determinazione eccezionale. Penitenza intesa come rinuncia, ma anche penitenza in senso attivo, con ricorso a strumenti: ha portato al collo per buona parte della sua vita una catena di ferro, che non toglieva nemmeno durante la degenza per malattia e un cilicio gli avvolgeva la per-sona. Per non dire dei vari tipi di “discipline”, che si era procurato e con cui si flagellava.
Un armamentario sado-maso diremmo oggi, se non fosse che abbiamo a che fare con una persona estremamente equilibrata, prudente, niente affatto esibizionista. Quella camicie e quelle maglie sporche di sangue che sua ma-dre e le sue sorelle per anni hanno trovato, sbrigativamente da lui pulite per non dare nell’occhio, sono tracce di una scelta di vita molto ardua ma molto efficiente.
Don Gaetano non si accontenta di essere un prete burocrate dello spirito. Esplora invece la sua anima, fino a confini estremi, per individuarne il tessu-to profondo e nascosto, quell’elemento che la collega al divino. E ritiene di dover fare lo stesso con le anime che gli vengono affidate. Per riuscire in questa impresa di esplorazione raffinata e delicata occorre ridurre al massi-mo la ruvidità, il peso, la resistenza: bisogna essere leggeri fino alla traspa-renza per trattare adeguatamente l’anima. La pratica della penitenza consen-te di raggiungere questa assetto ideale per comprendere la dimensione spiri-tuale di noi stessi e del mondo che ci circonda.
La penitenza non è distruttiva, dunque, ma creativa. Praticata da tutti co-loro che hanno voluto esplorare i livelli più profondi dell’esistenza è una delle componenti fondamentali dell’esperienza mistica, preso tutte le reli-gioni. Ma nel cristianesimo penitenza e mistica hanno assunto una valenza particolare: “Nella religione primitiva, il limite della mistica è segnato dalla magia, con i suoi fini pratici; nell’islamismo e nell’ebraismo è segnato dai comandamenti di Dio, potenza superiore; nel cristianesimo il limite è l’amo-re” .
Avesse voluto profittare dell’ambiente, profondamente impregnato di re-ligiosità magico-sacrale, don Gaetano avrebbe avuto tutte le possibilità di fare il santone e il taumaturgo. E di guadagnare in proporzione. Ha invece optato per il “limite dell’amore” e della sua vita da prete ha fatto un que-stione di cuore.
Lo dimostra a contatto con la massima espressione dell’amore, che è l’Eucarestia. Quando don Gaetano celebra si trasforma. Il contatto con il corpo di Cristo gli dà benessere anche fisico. Guarisce, sostengono i suoi confratelli.
Lo dimostra ancora con una straordinaria fede nella Provvidenza, pro-prio quella fede che sposta le montagne. Quella che gli fa arrivare il denaro necessario al momento giusto, per cui non si deve preoccupare di come e quando lo spende. Quella fede che gli consente di spostare tutto il suo impe-gno sulla produzione del bene, riducendo al minimo la funzione amministra-tiva e finanziaria: Dio fa volentieri il finanziatore e il commercialista quan-do l’impresa del bene produce al meglio. A Napoli e a Secondigliano, si co-nosce così bene questo particolare rapporto di don Gaetano con la Provvi-denza che ci sono dei commercianti disposti a riservargli libero accesso alla cassa, perché si serva come ritiene opportuno. Tanto sanno di non perderci.
Don Gaetano può permettersi, con il denaro della Provvidenza, di fare il grandioso. L’arredo delle sue chiese deve essere il meglio del meglio. Il gu-sto sarà anche tutto napoletano (ricco, ridondante), ma la fede ha la sempli-cità evangelica del bambino, che non può immaginare la casa del Padre se non nel modo più strepitoso e accogliente.
Preghiera, penitenza, fede. Ma per capire a fondo don Gaetano bisogna capire qual è l’obiettivo primario della sua vita: “Accendere nel cuore degli uomini, il fuoco del Divino Amore”.
Detta così sembra una arcaica frase devozionale. Ma basta tradurla in a-zione o vederla applicata da persone come don Gaetano per rendersi conto della carica dirompente che essa contiene: il cuore, il fuoco e l’amore sono materiali incendiari, socialmente e culturalmente pericolosi. Spade che ta-gliano al netto il sì e il no, il Bene e il Male, la luce e le tenebre.
In quanto prete del cuore, del fuoco e dell’amore, don Gaetano è radica-le. Là dove si offende Dio va come in guerra. Adotta tattiche diverse – invi-tare i clienti delle bettole a venire in chiesa, bloccare un ballo in piazza, im-pedire uno spettacolo di saltimbanchi mettendo per traverso alla porta di in-gresso del tendone un crocifisso – ma non rinuncia allo scontro. Ad affron-tare la gente armata di coltello è allenato.
Ovvio che la sua “pericolosità” anche socio-politica venga avvertita su-bito dai reazionari, come dagli innovatori e dai cospiratori. Ad essere peri-coloso è ciò che don Gaetano produce con la sua azione pastorale: le co-scienze ben formate (attraverso la scuola, la confessione, la missione) hanno una potenza di fuoco superiore a quella di qualsiasi esercito e cambiano il mondo in maniera irreversibile e definitiva (prospettiva che ogni rivoluzio-nario teme, perché ha sempre bisogno di assicurarsi una vita di fuga e un ri-torno indolore alla normalità). Ovvio che anche negli ambienti cattolici me-no avveduti, l’attività di don Gaetano abbia sollevato critiche, contestazioni, opposizioni di ogni genere.
È la prova del nove che don Gaetano sta incidendo profondamente nella realtà in cui vive.
Può sorprendere che gli strumenti da lui adottati siano appunto la parola, la preghiera, la penitenza, il servizio al prossimo. Siamo abituati a pensare che si tratti di strumenti inadatti a cambiare i rapporti di potere dei sistemi nei quali viviamo: politica, economia, scienza e tecnica non sono manovra-bili con la parola, la preghiera, la penitenza, la solidarietà. Ma si tratta di un banalissimo luogo comune. Sul quale pateticamente insistiamo, a dispetto della scomparsa definitiva di queste invenzioni della modernità. La storia è finita, dice qualcuno esagerando. Forse basta raccontarla in modo diverso.
Oggi abbiamo capito che la storia che ci siamo finora raccontati non ci ha insegnato nulla di interessante: la ripetiamo con scarsa fantasia e tanto spreco di mezzi e di persone. Il passaggio dalla guerra guerreggiata alla guerra umanitaria è un giochino di parole poco consolante. Continuiamo ad ammazzare per difendere i diritti umani (quelli codificati dalla Rivoluzione Francese).
A me pare che sia questo il motivo per cui abbiamo difficoltà a cogliere la straordinaria efficacia, anche sociale e politica, di un’impresa come quella di don Gaetano. Impresa che è squisitamente spirituale e proprio per questo innovativa.
La storia ufficiale non ha registrato più di tanto il suo contributo, abitua-ta a privilegiare altre dimensioni. Lo sta invece registrando la storia della Chiesa e lo chiama “santità”. La santità rientra in una affascinante tradizio-ne narrativa, grazie alla quale si tramanda di generazione in generazione un patrimonio eccezionale di esperienza pratica e di amore.
Leggere il “racconto” di Errico Gaetano oggi significa abbandonare per un momento il linguaggio tecnico-scientifico dominante, spogliarsi della ri-gida corazza rappresentata dal sistema di funzioni che presiede al nostro vi-vere individuale e sociale, per venire a contatto con parole antiche e quasi scomparse dal nostro lessico. Parole come preghiera, penitenza, fede, sacri-ficio, amore.
Basta superare il primo effetto di estraniamento, per renderci conto che quelle parole perdute ci sono più che mai utili per descrivere la nostra espe-rienza. Non servono per imbastire i discorsi superficiali, che alimentano il nostro bla bla quotidiano, ma per organizzare quel discorso profondo che ci serve per dare un senso alla nostra esperienza di vita.
Oggi, la diffusa ricerca di star bene con se stessi si manifesta nel ricorso a maestri di ogni tipo, a guru di ogni specialità, a tecniche e discipline di ogni latitudine. Ma le parole non cambiano: stiamo meglio, ma non sappia-mo dove siamo. E nemmeno dove stanno i nostri fratelli. Questa ricerca, quasi sempre onesta, ha una sua patetica dignità: è ricerca di un qualche co-sa che abbiamo a portata di mano da sempre.
La vita e l’opera di don Gaetano ne sono la prova. Tanto più convincente in quanto viene incontro alle nostre paure profonde, che si possono ricon-durre ad una sola: la paura del cuore.
Ora don Gaetano è un prete che per tutta la vita ha fatto una cosa sola: ha invitato tutti a non aver paura di ciò che il cuore può fare, “perché Dio è più grande del nostro cuore”.
In presa diretta con il Vangelo, don Gaetano ha elaborato una vera e propria pedagogia del cuore. Anzi una pedagogia dei due cuori: il cuore del-l’uomo più grande che abbia mai camminato sulla faccia della terra (Gesù) e quello della donna più donna di tutte (Maria).
Intuizione squisitamente moderna, psicologicamente avanzata: c’è un maschile e un femminile del cuore, come della Grazia, come della divinità. In caso contrario non si darebbe fecondità, ma solo clonazione.
E invece Dio ama la diversità.
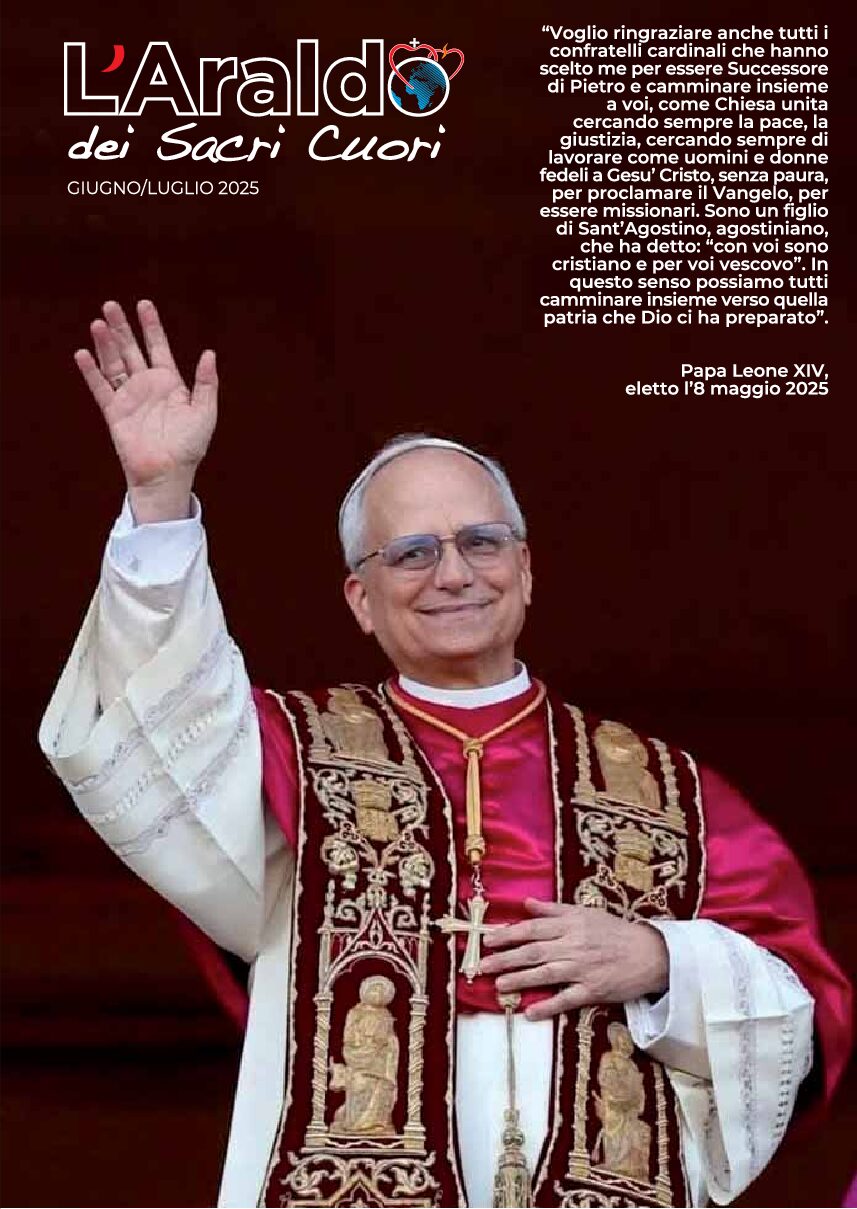
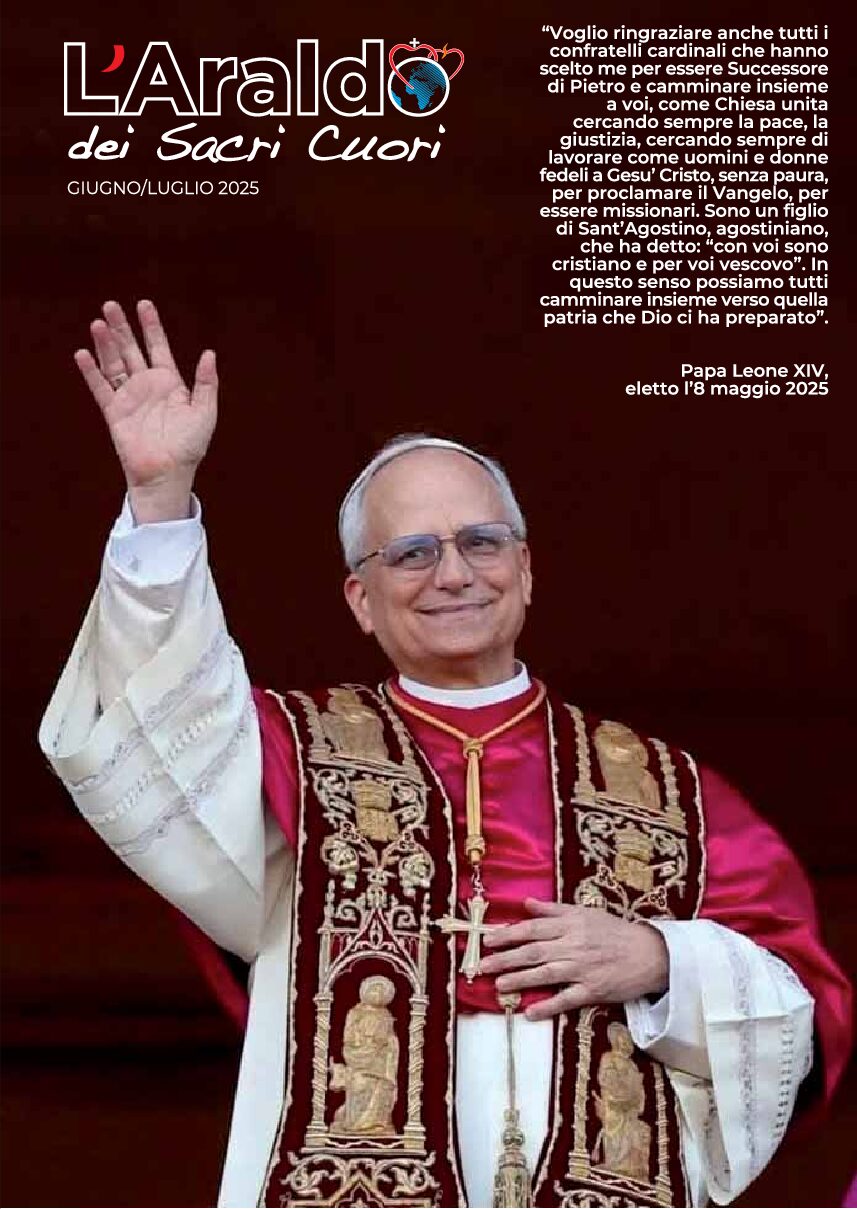
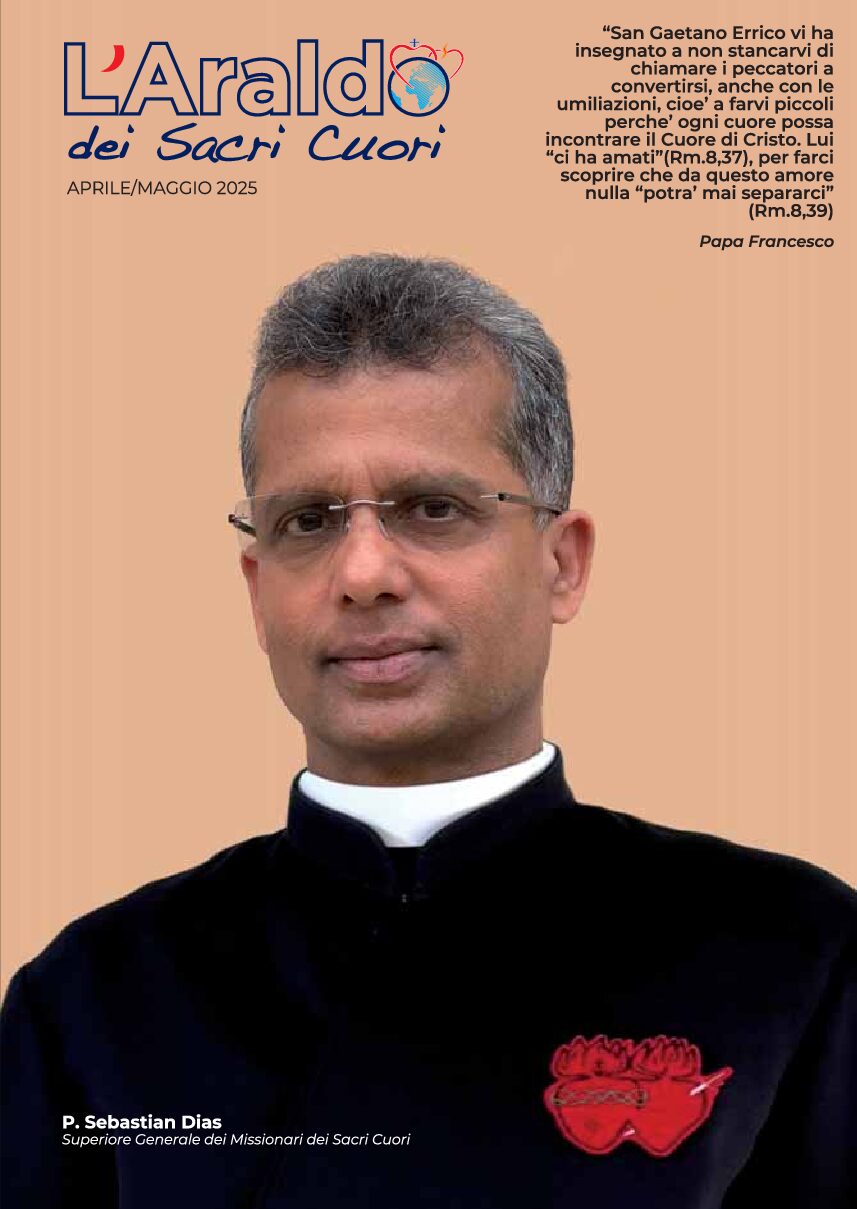




No Comment