Preparazione
Infanzia e adolescenza di Gaetano Errico sono segnate dalla paura, dalla violenza, dalla precarietà.
Ha cinque anni (1796) quando il Regno di Napoli firma accordi di pace con Napoleone. Ha otto anni quando vede passare le truppe fran-cesi che occupano la capitale per punire Ferdinando IV dell’aiuto pre-stato al papa per riavere Roma. I sei mesi della Repubblica Partenopea (1999) registrano conflitti di ogni genere tra le diverse fazioni e tra i reazionari. E quando Ferdinando IV rientra dalla Sicilia, dove si era rifugiato, si vendica con ferocia inaudita. Ha quindici anni quando Napoleone, che ha imparato a non fidarsi di nessuno dei principi sot-tomessi, il 14 febbraio 1806 invia a Napoli suo fratello Giuseppe Bo-naparte, che sostituirà poco dopo con il cognato Gioacchino Murat.
Sono tempi in cui per stare in piedi occorre avere idee chiare e muscoli saldi. Gaetano dispone di entrambi e una volta messo a punto il progetto della sua vita – diventare sacerdote – passa all’azione.
Bussa alla porta del convento dei Frati Minori Cappuccini, ma non viene accettato. Presenta domanda ai Padri Redentoristi, cono-sciuti a Secondigliano in occasione di una missione, ma un decreto re-gio che proibisce alle congregazioni di accettare nuovi adepti, lo tiene fuori dalla porta.
Tenta allora di entrare in seminario. A Napoli ce n’erano due di seminari: uno urbano, riservato ai giovani della città; uno diocesano, riservato ai giovani provenienti dai “casali dell’Archidiocesi”. Un du-plicato necessario, fino alla fine del Settecento, perché le domande di ingresso in seminario erano moltissime. Forse superiori al numero di vocazioni autentiche e comunque tante da rendere necessaria una qualche forma di selezione. Quando Gaetano si presentò, in seminario si entrava ancora per concorso, ma i tempi stavano cambiando e l’at-tacco ai privilegi del clero, condotto dalla rivoluzione francese prima e da Napoleone poi, modificherà profondamente la composizione e la qualità del clero napoletano e meridionale, oltre che del clero di tutta Italia e di tutta Europa.
Gaetano vince il concorso, indossa l’abito chiericale gentilmente regalatogli da una pia signora, ma in seminario non ci entra. In casa non ci sono soldi per mantenerlo agli studi. Viene così iscritto come “chierico esterno”: come dire che vive in famiglia pur frequentando le lezioni in seminario. A parte l’ottimo allenamento atletico dei 16 ki-lometri giornalmente macinati, l’aver evitato la vita del seminario gli ha permesso – a lui come ad altri sacerdoti napoletani, assicurano gli storici, che, a parità di esperienza, si sono particolarmente distinti nel-l’attività apostolica – di mantenere un contatto diretto con la realtà so-ciale ed economica del suo paese, con i problemi quotidiani dei suoi concittadini, dei giovani, delle famiglie. Il seminario, ieri più di oggi, era un ambiente protetto, accuratamente separato dal mondo, molto spirituale e poco pratico, che formava sacerdoti sapienti e pii ma spes-so lontani dalla vita reale dei fedeli al cui servizio venivano inviati.
Gaetano invece diventa prete senza reti di protezione. Sviluppa la sua vocazione attingendo dalla sua terra, dalla sua gente, dalla sua fa-miglia oltre che dai libri di teologia. Il che gli permette di caricare di concretezza la sua azione sacerdotale, come avremo modo di racconta-re. Un processo molto più faticoso, che lo costringe a contare solo sul-le sue possibilità e la sua resistenza.
In seminario si mette subito in evidenza. Il suo arrivo in classe in-nalza clima e impegno. Lo fanno prima Assistente del Circolo di Teo-logia Dogmatica e poi Principe di Teologia.
Eccola la fantasia lessicale napoletana: Gaetano vive con una pa-gnotta e due “grana” al giorno, che lui spende per acquistare qualche frutto e quello che risparmia gli serve per i libri e qualche regalo ai malati dell’ospedale degli Incurabili. Ma viene nominato principe e in questo principe con due grana, c’è l’ironia e il dramma dell’eterna ma-schera napoletana del povero intelligente.
Gaetano lo è ed è particolarmente dotato in matematica, il che rap-presentava una eccezionale opportunità di intraprendere la carriera ac-cademica diventando professore universitario. Sarebbe stata una buo-na soluzione, per uscire dalla precarietà economica e assicurare alla famiglia un futuro più sicuro e dignitoso. Per le famiglie povere di al-lora la “vocazione” al sacerdozio di un figlio risolveva spesso il pro-blema della sopravvivenza.
Non meravigli se agli inizi dell’Ottocento diventare preti si presen-tava come un progetto di vita in cui vocazione, interessi privati, re-sponsabilità familiari e disponibilità di un “patrimonio con sufficiente rendita” si mescolavano in maniera sorprendente. Siccome è da sem-pre che i giovani ricchi stentano a seguire il Signore e a entrare in se-minario, la vocazione sacerdotale trova maggiori ascolti e adesioni tra i giovani poveri. I quali sono “poveri” sul serio, in senso economico ma anche in senso psicologico e culturale. I criteri di selezione adottati dai seminari di allora non erano molto sofisticati, un po’ perché l’offer-ta superava il fabbisogno, un po’ perché la qualità del servizio sacerdo-tale era lasciata alle capacità dei singoli più che promossa nel periodo di formazione.
Deve invece sorprendere che nel clero dell’Ottocento ci siano stati tantissimi sacerdoti capaci e santi, pur avendo compiuto percorsi for-mativi poveri di contenuti e di motivazioni. Una situazione che si è prolungata in Italia fino ai primi decenni del Novecento e che eviden-zia come in una vocazione la risposta alla Grazia e la risposta alle sol-lecitazioni del Seminario o del Noviziato abbiano un ruolo decisamen-te diverso. E se oggi le vocazioni continuano ad arrivare dai paesi po-veri, significa che la formula funziona. Non mancano le vocazioni (il numero in assoluto dei sacerdoti nel mondo cresce ogni anno), forse ci sono solo troppi giovani ricchi. E un po’ sordi.
Questo abbiamo precisato perché la vicenda del figlio del macche-ronaio che diventa prete non è un luogo comune, una specie di prede-stinazione riservata ai giovani buoni e privi di mezzi, ma un progetto di vita in cui il povero sfida Dio a dimostrare che è lui il vero domina-tore del Regno. E la conquista del Regno è un affare da… giacobini, dice Gesù, perché non ammette mediazioni e piedi in due scarpe, ma scelte radicali e concrete: i ciechi vedono, gli storpi camminano, gli affamati mangiano, i lebbrosi guariscono, i morti risorgono e cambia il linguaggio, la parola assume un’altra funzione: non si limita ad espri-mere, salva.
Gaetano Errico diventerà appunto prete dei poveri, degli ammalati, della parola e della conversione radicale (che è molto di più di una ri-voluzione).
Pateticamente Gioacchino Murat aveva stabilito che i preti dove-vano essere ordinati in base alle esigenze di servizio: cinque ogni mil-le abitanti gli pareva una buona proporzione.
Gaetano rischia di non entrare nel numero legale e allora si presen-ta a Gioacchino Murat e gli dice che lui vuole fare il prete anche se il numero chiuso non glielo consente. Difficile dire se Murat abbia cedu-to per simpatia verso quel ragazzone che gli si è presentato senza al-cuna incertezza o se abbia ceduto perché Gaetano gli ha dimostrato molto concretamente quanto il suo decreto fosse cretino. Come che sia, Murat si esibisce in un comico: Sia come desideri, che sblocca la situazione.
E così Gaetano Errico diventa prete facendo il pendolare dalla ca-sa al seminario, per concessione del cognato di Napoleone e grazie al-la generosità del signor Pasquale Riccio, che fonda per lui una “cap-pellania laicale” nominandolo cappellano vitanaturaldurante.
Lo consacra sacerdote il Card. Ruffo Scilla, il 23 settembre 1815. Un prelato che aveva pagato e pagherà cara la sua opposizione agli in-vasori francesi.
Nello stesso anno Napoleone finisce a S. Elena, Murat viene scon-fitto dagli austriaci a Tolentino, Ferdinando IV ritorna a Napoli e prende il nome di Ferdinando I come per dire che adesso tutto ritorna da capo e si restaura quello che è stato scompaginato. Si conclude il Congresso di Vienna che smonta come un puzzle l’impero napoleoni-co.
Don Gaetano, prete novello, arriva a Secondigliano verso sera. Non vuole festeggiamenti e ingressi trionfali; saluta amici e parenti e si ritira in casa. Ha da mettere a punto la sua strategia apostolica. In linea con la splendida tradizione del clero meridionale dell’Ottocento e del Novecento, don Gaetano ha saputo armonizzare evangelizzazione e promozione dell’uomo, soprattutto del povero, con una formula ori-ginale, rispetto alla tradizione dei santi sociali che hanno operato nello stesso periodo nel Nord Italia.
Ha vissuto il suo sacerdozio in un momento storico – dalla restau-razione (1815) all’unità d’Italia (1860) – complesso e contraddittorio. Dall’analisi e dagli strumenti da lui adottati per svolgere la sua missio-ne di prete possiamo capire quanto sia stata acuta la sua comprensione della situazione sociale, economica, politica e religiosa, in cui viveva.
Emerge anche la sua figura di prete alternativo.
Il prete alternativo
Lo stato del clero napoletano e meridionale, dopo il tornado della rivoluzione, era preoccupante. Drasticamente ridotto dalle leggi re-strittive e dalla soppressione degli Ordini e delle Congregazioni reli-giose, era inquinato da circa 2000 presenze di preti così detti “regnico-li”, perché venuti a Napoli da altre diocesi del Regno, quasi sempre senza permesso dei vescovi, per motivi di studio o per scappare dalla povertà endemica delle loro regioni di origine. C’è chi fa il filo alla ri-voluzione e accumula cariche, onori e soldi per poi perdere tutto a ri-voluzione conclusa, e chi va ad ingrossare le file degli emarginati e dei devianti della città.
Ci sono anche degli ottimi sacerdoti, per dirla tutta, ma la condi-zione dei preti sbandati è critica al punto tale da rappresentare un pro-blema di ordine pubblico. Il marchese Tommasi, capo della Polizia, scrive in una relazione dell’agosto 1815 che molti sacerdoti ” non a-vendo mezzi di sussistenza e abbandonati a tutti i disordini della dis-solutezza, menavano la loro vita nella umiliazione e di una maniera indegna del loro carattere, frequentando le bettole e i bordelli e met-tendo spesso a profitto gli oggetti più santi del loro ministero”.
Ai “regnicoli” bisogna aggiungere un certo numero di preti di rap-presentanza che non esercitavano il ministero, limitandosi ad ammini-strare il loro patrimonio e a fare da precettori e cappellani presso le famiglie nobili, in totale autonomia dal proprio vescovo.
C’erano poi i religiosi soppressi: quei frati cioè che a seguito delle leggi anti ecclesiastiche erano stati costretti ad abbandonare i loro conventi. Alcuni se ne sono tornati al loro paese e sono diventati con-correnti dei sacerdoti secolari, in quanto riducevano le già magre ren-dite provenienti dai patrimonio ecclesiastici. Altri si sono imboscati in case private, normalmente in città, e si sono rifiutati di esercitare il ministero.
Al suo rientro dal confino, il cardinale Ruffo Scilla, trova un clero povero spiritualmente, culturalmente ed economicamente. Preti che non riuscivano a superare la soglia della miseria e si disputavano l’esi-stenza ai piedi dell’altare. Le differenze economiche erano drammati-che: mentre le categorie privilegiate dell’alto clero secolare e dei mo-naci possidenti vivevano nel lusso e dell’abbondanza, la grande massa del clero viveva nella miseria, costretta “per campare la vita ai mestie-ri più disparati e più vili, da mediatori nei mercati a usurai, da taver-niere nell’osteria fino a contrabbandiere” come si legge negli Atti di una visita apostolica dello stesso card. Ruffo.
Su questo sfondo, la scelta di Gaetano Errico assume una partico-lare rilevanza. Il suo rifiuto di impiegare il sacerdozio come occasione di riscatto sociale è in contro tendenza. Come lo è il suo rifiuto di in-traprendere la carriera universitaria, facendo l’intellettuale di profes-sione e il prete di complemento. Lo è anche il suo drastico rifiuto di partecipare a sagre e feste paesane, a spettacoli e ad altre forme di di-vertimento e di dissipazione. Non è il rifiuto snob di chi non si mesco-la con il popolo, ma una scelta di campo precisa.
C’è uno stile in ogni progetto di vita, nel sacerdozio come nel ma-trimonio, che fa parte della sostanza, in quanto salvaguarda la dignità della persona prima di salvaguardare il valore della missione. Il clero del suo tempo aveva perso la propria identità di ruolo forse perché non era riuscito a rispettare la propria dignità personale.
Gaetano Errico disegna il suo progetto sacerdotale sviluppando una provocazione fortissima: fare il prete da povero.
Per operare un salto di classe sociale poteva benissimo fare il mac-cheronaio: aveva competenza professionale, intelligenza e credibilità sociale. Premesse ideali per un imprenditore della pasta. E invece de-cide di fare il prete, ben sapendo che sotto l’apparente stima di cui questa figura gode in paese si nasconde disprezzo e squalifica. In tutte le società chiuse la devianza gode di una specie di riconoscimento uf-ficiale e persino di una certa stima: un meccanismo di difesa per evita-re che la devianza stessa diventi distruttiva. È il giusto terreno di col-tura della criminalità, che trova così il modo di organizzarsi, sfruttan-do quella specie di legittimazione rassegnata che si chiama omertà.
Gaetano Errico è troppo ben inserito nel suo contesto sociale per non sapere queste cose. E sa benissimo che fare il prete non gli assicu-ra automaticamente nessun valore aggiunto. Dovrà metterci del suo sia per superare la caduta di immagine sociale del sacerdozio sia per assi-curare l’efficacia del suo servizio.
E lo farà, prima di tutto, mediante un uso creativo della parola.
La parola creativa
Don Gaetano vive in un periodo di grandi parole.
Quelle che dalla Francia si diffondono in Europa e in Italia fino a Napoli grazie agli agenti della rivoluzione, provengono da una specie di bibbia scritta da D. Diderot e J. B. d’Alembert, assieme ad una cin-quantina di collaboratori, tra il 1751 al 1772.
Si tratta della Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, nella quale sono raccolte le idee degli intellet-tuali di allora circa la scienza, la morale e la religione. Il curioso di questa opera, per molti aspetti straordinaria, è che ogni disciplina vie-ne affrontata in polemica con la dottrina cattolica. Una specie di pre-suntuosa anti-Bibbia, che per molti diventa il libro unico e l’unica fon-te di verità. L’Enciclopedia apre le porte ai principi della rivoluzione e avvia quel filone di pensiero e di comportamento laicista, che ancora oggi non riesce a liberarsi dai pregiudizi e dai luoghi comuni e si osti-na a considerare la ragione come unico criterio di valutazione e di ve-rità e la fede come un modo irrazionale di guardare al mondo e alla storia.
Le parole dell’Enciclopedia assumono ben presto agli orecchi di molti un significato nuovo. E più vengono ripetute e sbandierate e più sembrano vere. Quando, in occasione dei disordini rivoluzionari pari-gini, vengono addirittura urlate e chi non le ripete viene ghigliottinato, a molti pare di essere finalmente approdati al nuovo mondo e alla nuova cultura. L’illusione dura poco, ma le parole messe in circolazio-ne resistono, diventano linguaggio e dunque modo di vivere e di ra-gionare: chi le sa usare si considera un uomo nuovo; chi non le sa usa-re viene considerato un reazionario. C’è chi si fa maestro della nuova lingua, chi cospira e parla di nascosto, chi scrive documenti anonimi, chi battezza proseliti del nuovo verbo di nascosto. Modificate nella sintassi, ampliate con qualche ulteriore significato, depurate di qual-che esagerazione sono tuttora impiegate dalla cultura laica e valorizza-te come patrimonio irrinunciabile.
Sono parole importanti e certamente nobili. A fare problema sono i discorsi che con quelle parole alcuni intrecciano. Ieri come oggi.
Don Gaetano sa bene che anche a Secondigliano circolano nuove parole, sa che ignoranza e analfabetismo espongono il popolo al ri-schio di usarle in discorsi pericolosi, per cui decide di mettersi a servi-zio della sua gente in due modi: facendo scuola e predicando.
La cattedra e il pulpito sono laboratori di parole. E sono esempi di come le parole si possono organizzare in racconti (scuola) e in discorsi (predica).
A Secondigliano faceva il maestro il sacerdote don Michele Vita-gliano, collaboratore del parroco don Michelangelo Franco. Nel 1810 questi muore e don Vitagliano gli succede: il doppio incarico di mae-stro e di parroco gli torna troppo gravoso e difficilmente gestibile. Si dimette da maestro.
Il Municipio, prende atto delle dimissioni e presenta al Ministero della Pubblica Istruzione, tre possibili candidati. Della terna fa parte anche don Gaetano, che viene scelto: tutti gli riconoscono dottrina e capacità di trattare con i ragazzi.
“Fare scuola” appartiene alla più antica tradizione educativa. Risa-le ai tempi più antichi anche l’abitudine che a fare da maestri siano le persone più prestigiose e affidabili come i sacerdoti, gli scribi (quelli che sanno leggere e scrivere), i filosofi, gli anziani.
Il cristianesimo perfeziona questa tradizione, facendo fare alla scuola un salto di qualità: il Maestro diventa un tutt’uno con la sua dottrina, con la sua parola. Diventa parola viva, incarnata, che non si apprende soltanto ma si com-prende, si assume, si mangia, si metabo-lizza. Gesù diventa il modello di ogni maestro.
In un periodo storico in cui dominano i professori nelle nuove di-scipline, don Gaetano (che aveva i numeri per fare il professore di ma-tematica) decide invece di fare il maestro. La differenza tra maestro e professore è che il professore si accontenta che tu ripeta le parole che lui ti ha insegnato nello stesso ordine in cui te le ha insegnate; il mae-stro vuole invece che tu traduca quelle parole in un discorso tuo, in un comportamento valido, autonomo. Che usi le parole per vivere. Il pro-fessore insegna che cos’è la vita, il maestro insegna invece l’arte di vi-vere.
È questo che don Gaetano propone ai suoi allievi, con molta de-terminazione ed energia. Didatticamente abile, deciso nel tenere la di-sciplina stante il temperamento brillante dei ragazzi napoletani, li sa motivare all’apprendimento. E ottiene notevoli risultati. Nel senso che introduce nella società del suo tempo un consistente gruppo di profes-sionisti, di sacerdoti, di artigiani che sanno essere protagonisti nel set-tore in cui operano.
Don Gaetano faceva lezione dalle nuove alle undici e poi guidava i suoi allievi in chiesa per la messa, senza costrizioni, ma con il preciso intento di stabilire un collegamento tra la parola e la vita, tra la parola da dire e quella da mangiare.
E però la sua alzata di ingegno è un’altra: quella di collegare in di-retta cattedra e pulpito, scuola e chiesa, strada e casa mediante la paro-la. Un gioco comunicativo che affascina subito i suoi compaesani.
Non era una grande oratore. Ricorreva qualche volta a certi curiosi stili comunicativi come il contraddittorio: il parroco tra le gente gli poneva delle domande e lui dal pulpito rispondeva. La predica diven-tava un talk show come diremmo oggi. E poteva durare ore, perché don Gaetano era così bravo a rendere comprensibili le parole che di-ceva (ricorrendo anche al dialetto) che gli ascoltatori non si stancava-no.
Del suo modo di far scuola e di predicare non conosciamo né i contenuti né il metodo. E però il successo che sistematicamente otte-neva sta alla base della sua fama di sacerdote competente e santo. Il che significa che la sua parola produceva effetti, produceva cambia-mento.
Gli innovatori autentici puntano tutti sulla parola per cambiare il mondo in cui vivono.
Se ne sono accorti i suoi avversari, che hanno cominciato prima ad avvertirlo, poi a minacciarlo, poi a bastonarlo di santa ragione dopo averlo legato ad un albero assieme al parroco.
E siccome don Gaetano non la smetteva di opporre la sua visione del mondo alla loro, hanno assoldato un sicario per fargli la pelle. La persona prescelta fu un certo Giuseppe Scippa, detto il Pelliccione, a-bile nel maneggiare il coltello.
L’agguato avviene in un pomeriggio domenicale. Il Pelliccione si apposta dietro un portone, che dà sulla strada da cui sarebbe passato don Gaetano per raccogliere, come al solito, la gente da condurre in chiesa. Qualcuno vede tutto e lo avverte del pericolo. Il giovane prete non scappa, imbocca deciso la strada dell’agguato, spalanca il portone, disarma il Pelliccione e lo abbraccia.
– Vieni, con il padre tuo – gli dice e sembra lo stesso discorso fatto da altri al buon ladrone. Un discorso che liquida tutte le diatribe sui delitti e sulle pene, sulla rieducazione, sulla prevenzione e sulla repressione. Ai delinquenti noi diciamo, da sempre: “Vai” sulla forca, “Vai” in galera, “Vai” in tribunale. Li allontaniamo, li isoliamo nella loro azione delittuosa e li confermiamo in essa, con le nostre parole. Don Gaetano no, lui dice: “Vieni”.
È questo efficace capovolgimento del discorso che manda in be-stia i settari di ogni risma che a Napoli e dintorni cercano in tutti i modi di far passare le nuove parole, ma non riescono a far altro che a mettere insieme i vecchi discorsi della violenza, della prepotenza, del-la forza.
La rivolta antinapoleonica si sviluppa in tutta Italia attraverso l’at-tività di una serie innumerevole di sette segrete. Ce ne sono anche di estrazione cattolica come la Società del Cuore di Gesù in Romagna, i Trinitari e i Calderari in Calabria e nelle Puglie, l’Amicizia Cristiana in Piemonte. Fondamentalisti senza seguito. Con il crollo finale del dominio napoleonico entrano in azione anche i briganti e i soldati sbandati, che organizzano un movimento di resistenza negli Abruzzi, nelle Puglie, in Calabria con motivazioni e obiettivi molto ridotti.
Le società segrete più diffuse sono quelle che si rifanno diretta-mente o indirettamente alla massoneria. Si colorano di ideologie di-verse, dal liberalismo all’egualitarismo, passando anche per il cattoli-cesimo, e hanno come obiettivo l’indipendenza, più che la rivoluzione.
In Italia meridionale si sviluppa soprattutto la Carboneria, che at-tecchirà al Nord dopo il 1814-1815. Nelle ex Legazioni Pontificie prende invece piede la Guelfia.
Il limite delle sette è che non riescono a coinvolgere le masse po-polari per il semplice motivo che non hanno niente di comprensibile da dire e niente di concreto da dare.
Il successo di pubblico e di seguaci di don Gaetano dipende invece dal fatto che i suoi discorsi sono applicabili, rispondono a reali biso-gni delle persone e dunque credibili. A questo don Gaetano sapeva aggiungere una buona capacità polemica per smontare le idee dei set-tari e denunciarne l’inefficienza.
Il “maestro” Don Gaetano non ha bisogno di schierarsi né con la restaurazione né con la rivoluzione. Lui sa che il potere è la capacità di produrre cambiamento e che la sua gente questa capacità non ce l’ha perché non possiede la “parola”. Con la scuola e con la predica-zione, il giovane prete di Secondigliano dà ai suoi compaesani la paro-la e quindi la capacità di base per cambiare la loro condizione. E la gente lo capisce.
Alla politica dello scontro distruttivo dei rivoluzionari e dei pre-sunti innovatori, don Gaetano oppone la politica della parola costrutti-va: infatti, educazione e evangelizzazione sono due modi di impiegare le parole per “costruire” le persone.
Tra le due prospettive non c’è mediazione. La politica dello scontro distruttivo viaggia sulle punte dei coltelli e degli archibugi, delle baio-nette e delle bombe intelligenti. La politica della parola viaggia sulla punta della lingua e del cuore.
La vicenda di don Gaetano è qualche cosa del genere: inizia con la parola sulla punta della lingua (catechismo, scuola, predicazione), prosegue con la diffusione della parola (missione), si perfeziona defi-nitivamente con la politica del cuore, dei due “sacri cuori”.
L’attualità di don Gaetano ci pare consista proprio in questa strate-gia comunicativa con cui ha sviluppato la sua azione apostolica. Infat-ti, il suo è un piano di comunicazione da manuale.
Una volta individuato il target preciso (i destinatari del suo mes-saggio), ne studia le abitudini, le esigenze, gli interessi, i bisogni; ela-bora un prodotto di grande impatto emotivo e razionale; lo diffonde di porta in porta, con una tecnica anticipatrice del direct marketing (non è pubblicità in buca e nemmeno messaggio telefonico ma invito per-sonalizzato al destinatario); valuta i risultati, controllando il livello di cambiamento che è riuscito a produrre. E non si stanca mai di lanciare il suo messaggio. Ottimo testimonial, sapeva ottenere l’effetto persua-sione senza prevalere sul messaggio.
Non c’è alcuna forzatura in questa interpretazione, se il lettore tie-ne presente che uno dei manuali fondamentali della pubblicità è il Vangelo e che don Gaetano il Vangelo lo conosceva a fondo.
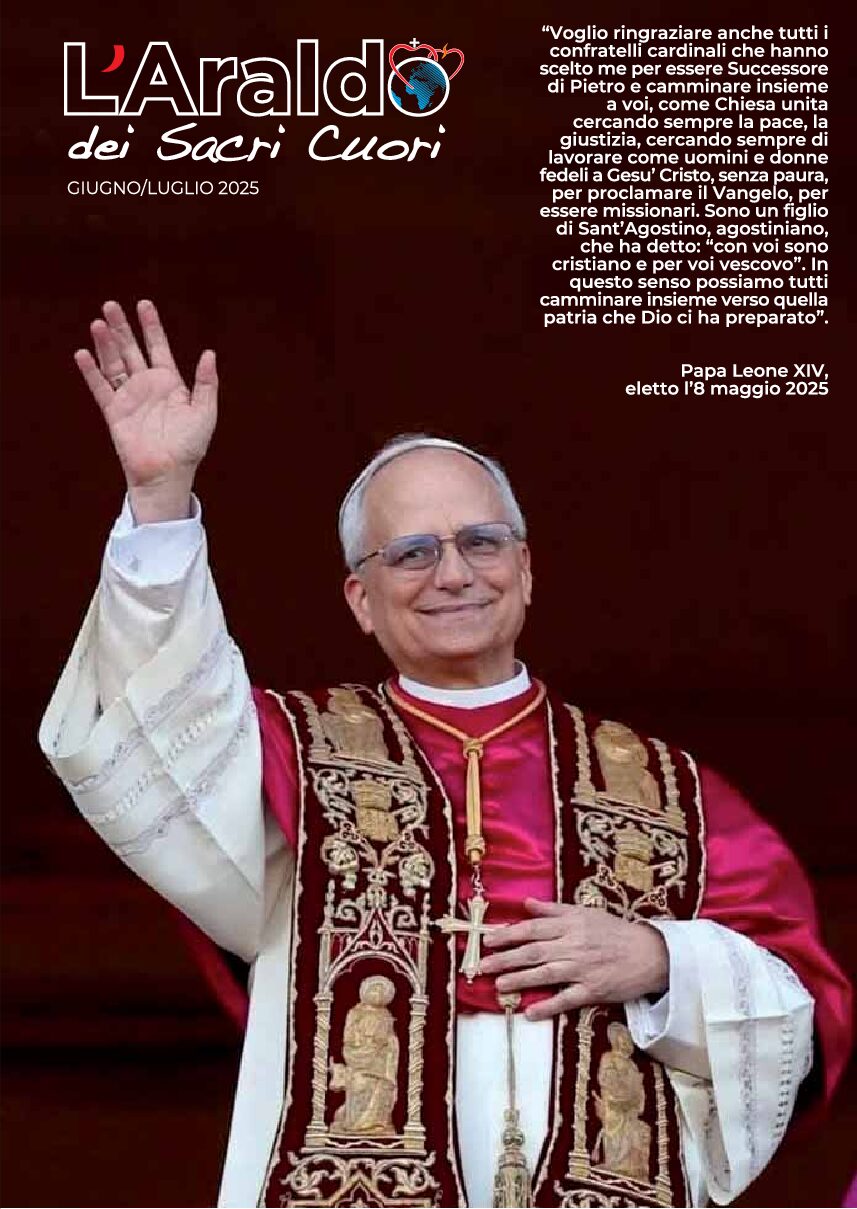
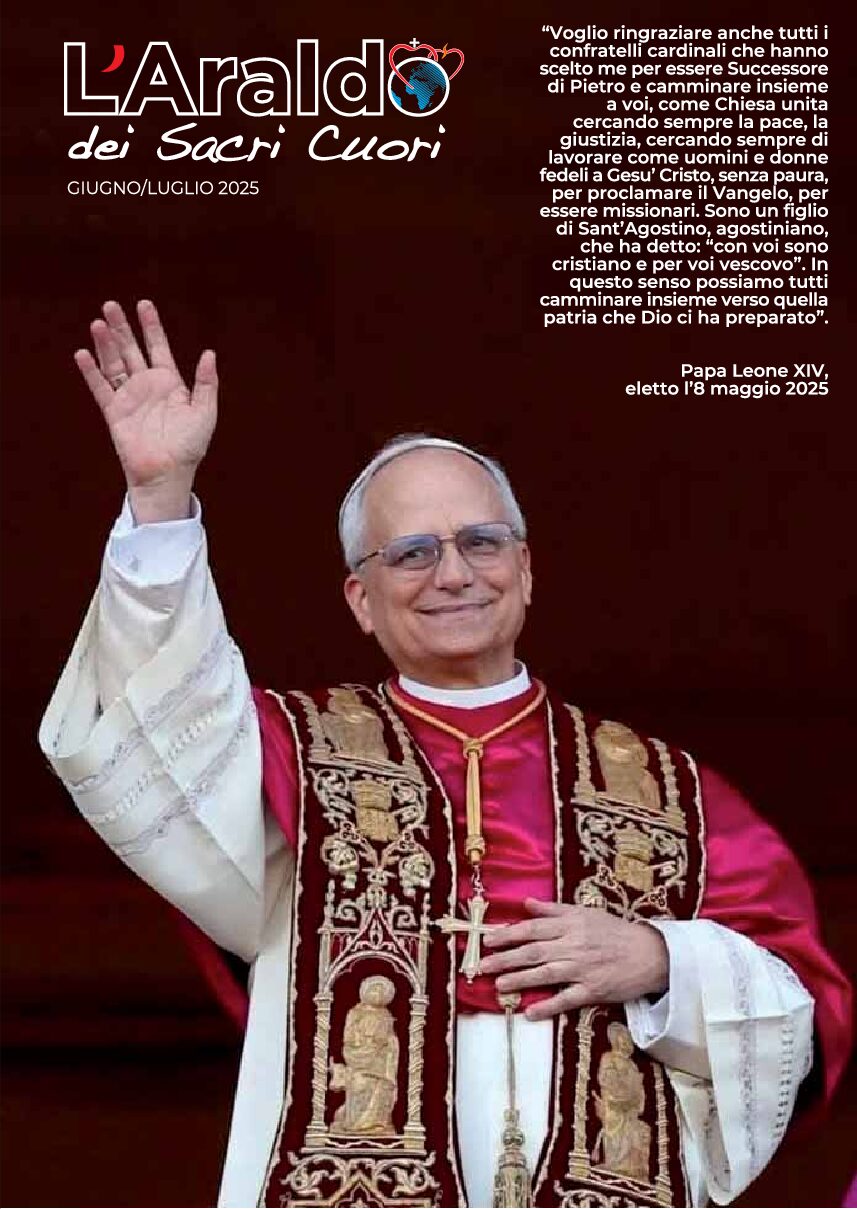
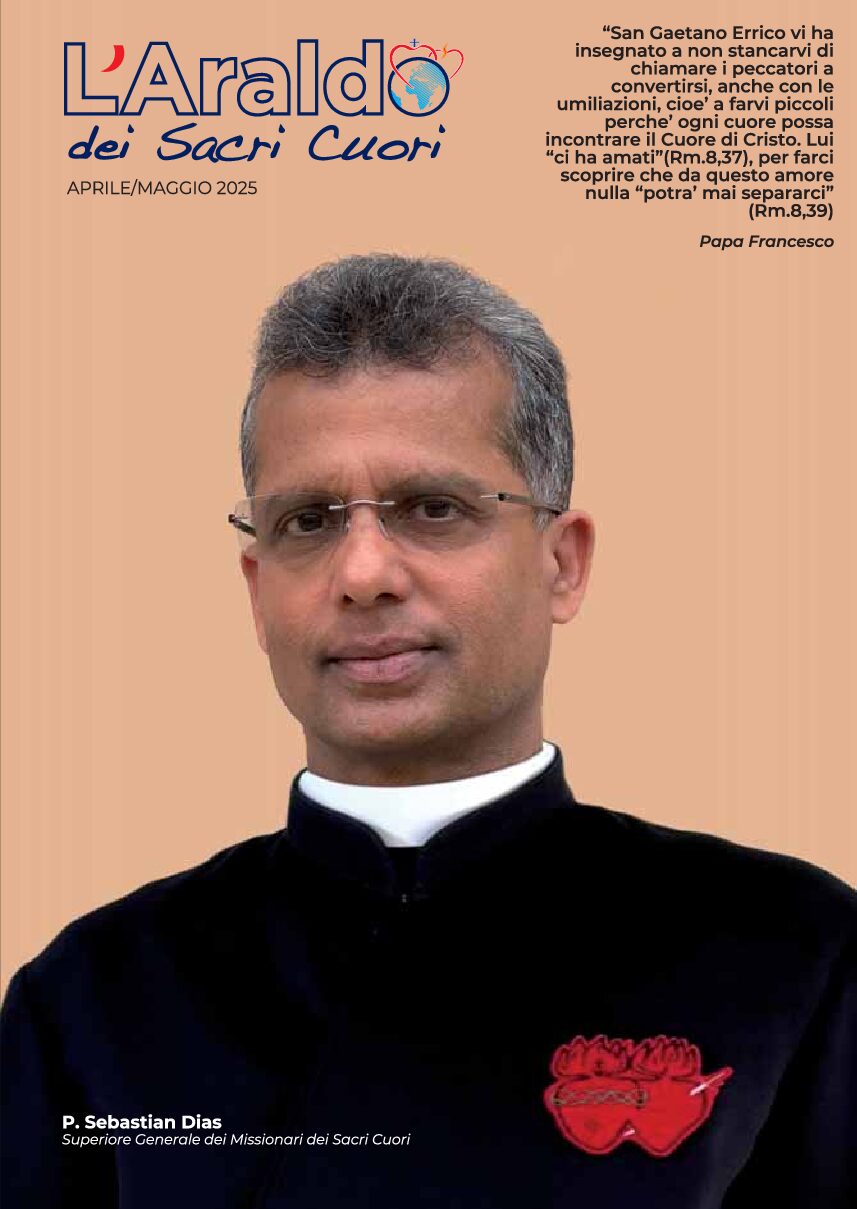




No Comment